QUALE INTERESSE HA IL POTERE CAPITALISTA E NEOLIBERISTA A DARE A TUTTI GRATUITAMENTE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE?
Già a pochi mesi di distanza è ormai chiaro che il 30 novembre 2022
non resterà soltanto una data da ricordare negli annali della
tecnologia, ma un momento di svolta epocale. Quel giorno, con il
lancio pubblico di ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI, si è
aperto un nuovo capitolo nel rapporto tra esseri umani e intelligenza
artificiale. L’annuncio ha suscitato entusiasmo e timori, curiosità
e dibattiti, perché ciò che è avvenuto non è solo l’introduzione
di un nuovo strumento digitale, ma l’emersione di una tecnologia
capace di ridefinire il nostro modo di comunicare, lavorare e persino
pensare.
L’intelligenza artificiale non era una novità
assoluta: già prima di ChatGPT era parte integrante della vita
quotidiana, seppur in modo meno evidente. La usiamo quando il
telefono si sblocca riconoscendo il nostro volto, quando un’app di
navigazione calcola il percorso più veloce, quando un sistema di
traduzione automatica ci aiuta a comprendere un testo in lingua
straniera. In tutti questi casi, si tratta di macchine che
riproducono capacità tipicamente umane, come il riconoscimento di
pattern, il linguaggio o la risoluzione di problemi. Ciò che
distingue ChatGPT è però la natura generativa dell’intelligenza
artificiale su cui si basa. Non più soltanto uno strumento che
analizza e restituisce dati, ma un sistema capace di produrre
contenuti originali a partire dall’enorme quantità di informazioni
con cui è stato addestrato. Un salto che, per molti versi, somiglia
all’idea di creatività, anche se nasce da algoritmi e non
dall’immaginazione umana.
Il successo di ChatGPT è stato
immediato e travolgente. La sua interfaccia semplice, basata su uno
scambio conversazionale naturale, ha reso accessibile a chiunque una
tecnologia complessa che, fino a poco tempo fa, era confinata ai
laboratori di ricerca e alle aziende specializzate. Basta digitare
una domanda o un comando e il sistema risponde con testi articolati,
spiegazioni, riassunti, e perfino con poesie e racconti. In soli
cinque giorni dall’apertura al pubblico, la piattaforma ha
raggiunto un milione di utenti: un ritmo di adozione senza
precedenti. La rapidità con cui si è diffusa dimostra quanto fosse
forte la domanda di strumenti in grado di semplificare compiti,
fornire risposte rapide e sostenere la creatività personale o
professionale.
Le opportunità sono enormi. Nell’istruzione, ChatGPT può diventare un tutor virtuale capace di adattarsi al livello e alle esigenze di ogni studente. Nel lavoro quotidiano, può ridurre il tempo speso in attività ripetitive come la redazione di e-mail o la ricerca di informazioni, lasciando più spazio ad attività strategiche e creative. Per ricercatori, imprenditori e professionisti, rappresenta un alleato potenziale nella sperimentazione e nell’innovazione. Ma accanto a queste prospettive si affacciano interrogativi cruciali. L’uso dell’intelligenza artificiale non può e non deve sostituirsi al pensiero critico umano: al contrario, lo esige con più forza. Le macchine generano testi plausibili, ma non sempre accurati; possono restituire risposte convincenti, ma anche imprecise o fuorvianti. Sta a noi, dunque, sviluppare nuove competenze cognitive, saper porre domande migliori, valutare con attenzione ciò che riceviamo e non rinunciare mai al ruolo di pensatori e creatori. Già dopo pochi mesi di utilizzo ho compreso che, a differenza di quel che credono molti addetti ai lavori, ciò che è veramente importante non è come scrivere le domande all’IA, il cosiddetto prompting engineering, ma la chiarezza di pensiero che deve esserci dietro a quelle domande, ovvero il critical thinking engineering. L’ingegnerizzazione del pensiero critico però non significa, almeno secondo me, una riduzione del pensiero a procedura “ingegnerizzata”, semmai il contrario. Si deve cercare di essere più aggiornati sulle informazioni che contano e più elastici nei ragionamenti che mai. È una sfida che la storia ci pone davanti: chi ha le capacità e l’opportunità di migliorare le proprie capacità intellettive non deve tirarsi indietro, ma ampliarle e amplificarle anche per esser d’aiuto a coloro che non possono. Si tratta di un compito arduo, lo so, ma non scorgo un'alternativa.
Arriviamo dunque a rispondere alla domanda posta nel titolo di questo articolo: “Quale interesse ha il potere capitalista e neoliberista a dare a tutti gratuitamente l'intelligenza artificiale?” La questione dell’accesso gratuito all’intelligenza artificiale, in particolare a strumenti come ChatGPT, solleva interrogativi legittimi sul ruolo del potere capitalista e neoliberista, perché ogni innovazione dirompente viene spesso interpretata come il frutto di una strategia politica o economica preordinata. Nel caso dell’IA generativa, però, questa lettura rischia di semplificare eccessivamente una vicenda molto più complessa. Per capire come sia nato ChatGPT e perché sia stato inizialmente reso accessibile gratuitamente, bisogna guardare al suo percorso tecnico e scientifico. Fino al 2017, infatti, non esisteva l’architettura che ha reso possibile lo sviluppo dei moderni modelli generativi: la svolta arrivò con il paper di Google Attention Is All You Need, che introdusse i Transformer, un’innovazione capace di rivoluzionare il Natural Language Processing e di permettere al linguaggio di essere elaborato in modo più efficiente e coerente su larga scala. Tuttavia, la vera accelerazione si ebbe solo a partire dal 2020, quando divenne chiaro che l’applicazione dei Transformer a quantità sempre più imponenti di dati, combinata con l’uso di hardware potente come le GPU, produceva un miglioramento esponenziale delle performance. Si scoprì così che aumentando i dati e la potenza di calcolo emergevano nuove capacità, inattese e sorprendenti, come la possibilità di sostenere conversazioni complesse o di generare testi creativi. Questo processo non è stato il risultato di un disegno economico o politico prestabilito, ma di un’esplorazione scientifica e ingegneristica che ha condotto a scoperte non previste. La scelta di offrire gratuitamente l’accesso a questa tecnologia rispondeva più a una strategia di mercato – utile a raccogliere feedback su vasta scala e a consolidare un ruolo di leadership nel settore – che a un piano ideologico di controllo. In altre parole, è stata l’innovazione tecnologica a precedere il modello di business e non viceversa.
Per concludere, il futuro che si sta delineando non è un futuro in cui l’intelligenza artificiale prende il posto di lavoro dell’uomo, ma un futuro in cui il nostro impegno intellettuale diventa ancora più necessario affinché non ci siano pochi uomini che con l’intelligenza artificiale prendano ed eliminino molti posti di lavoro di tanti uomini. ChatGPT ci pone davanti a una sfida: imparare a convivere con strumenti potenti che possono ampliare le nostre possibilità, a patto di usarli con consapevolezza e responsabilità. In questo senso, l’alba del 2023 appare come l’inizio di una nuova era, in cui l’intelligenza artificiale ci obbliga a essere non meno umani, ma più umani che mai.
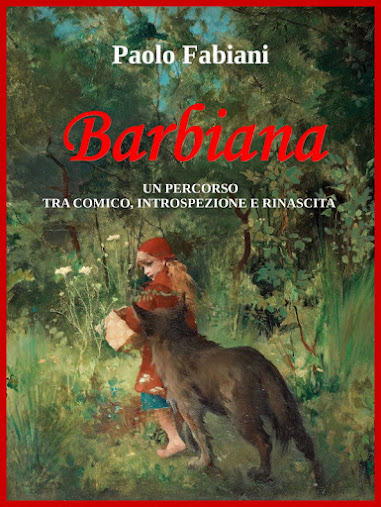

Commenti
Posta un commento